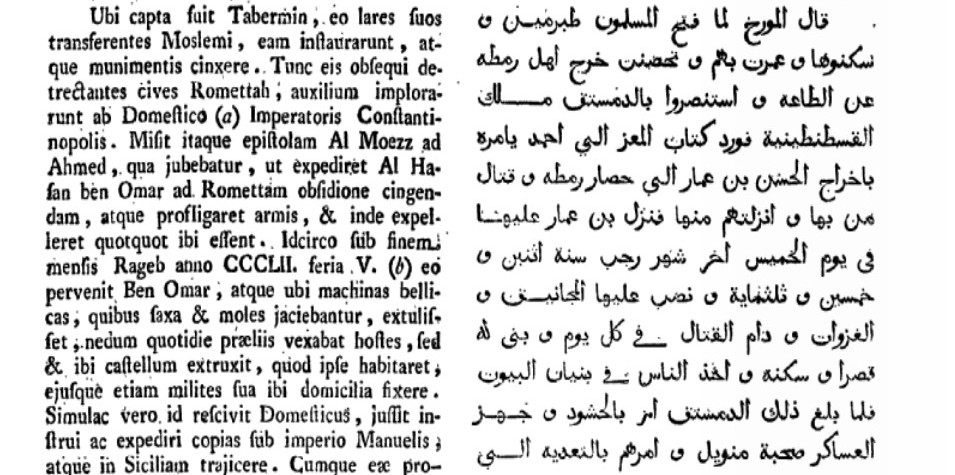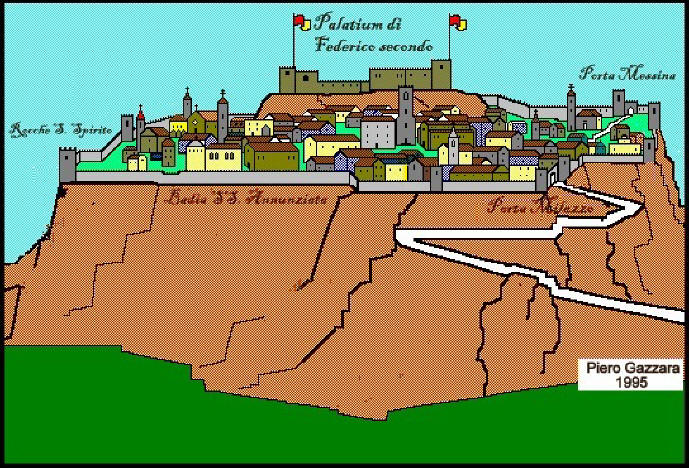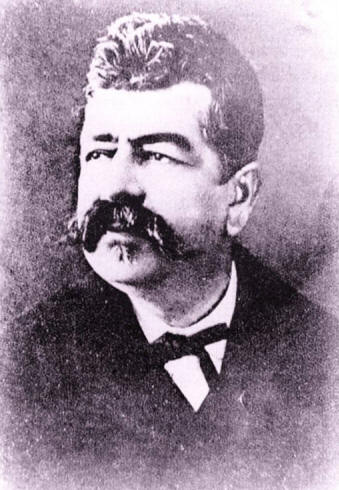|
Il sistema delle fortificazioni di Rometta e i fatti d’armi: dai
bizantini all’età moderna.
Estratto della relazione di Piero Gazzara presentata nel Convegno di Studi Immagini, Scritture, Pietre:
territorio e identità nella storia di Sicilia, tenutosi presso
l'Università di Messina e nel Comune di Furnari nei giorni 10 e 11
Novembre 2018. (Pubblicato in Archivio Nisseno, Rassegna di storia,
lettere, arte e società della Società Nissena di Storia Patria, a
cura di Luciano Catalioto, Raffaele Manduca e Luigi Santagati, Anno
XIII, n. 24, supplemento n. 2, ISSN 1974-3416, pp. 419 - 437)

J. B. B. D'Anville, Complete Body of Ancient Geography, London 1795
Rometta, questa sconosciuta. Ancora oggi è possibile individuare i
segni compositi di un passato ricco di eventi in cui leggere le
risposte al perché il Regno di Sicilia, ma più di tutti Messina,
cercavano di fare affidamento sulla fedeltà e controllo di un centro
abitato che sorgeva in cima ad una difficile collina, dall’aspetto
di montagna, in un territorio montuoso, tagliato da profonde vallate
alluvionali, esposto a venti impetuosi, raggiungibile da strade
mulattiere «che apparivano accessibili solo agli armenti» per dirla
con le parole di un viaggiatore irlandese di inizio 800 . Eppure in
cima a questo rifugio tra le montagne, situato sul versante
tirrenico dei Monti Peloritani, la gente vi è vissuta da tempi
remoti. E ci vive ancora.
Siede [Rometta] a cavaliere sopra un monte
presso i sottostanti comuni che ne dipendono, come da antica lor
madre, ed offre comodo accesso per due porte, presso le quali
esistono i ruderi dei grandi e solidi castelli che la rendevano un
tempo inespugnabile. Cinta di merlate mura, presenta tuttora
l’imponenza di una delle più antiche città dell’isola, che contrastò
sempre al dominio straniero. Non molti anni addietro è stata cinta
di nuove mura, ristorata e fatta più bella, essendoché l’orribile
terremoto del 1783 l’aveva quasi interamente distrutta .
La descrizione appena fatta risale al 1869 e pennella, a chiare
tinte, la funzione che ebbe la piccola terra, poi dal 1647 città
demaniale, di Rometta, erede della bizantina Erymata e della
medievale Rametta. Oggi, è centro amministrativo di un comune
del messinese tirrenico posto tra Capo Rasocolmo e il promontorio di
Milazzo di fronte alle isole Eolie, che conta 6.541 residenti ,
divisi tra i piccoli borghi collinari e il grosso centro costiero di
Rometta Marea.
Il centro storico, occupa interamente l’area sommitale per un totale
di 21 ettari circa, delimitata da tutti i lati da pareti rocciose
precipiti. L’ampio terrazzamento con un perimetro di circa 2,3 km.
rappresenta l’archetipo antico di un sito fortificato d’altura
che avvalora l’immagine di una Sicilia del passato, vista come
isola-fortezza perennemente soggetta ad attacchi esterni che la
trasformavano spesso in un luogo di frontiera tra occidente ed
oriente e, insieme, baricentro millenario di politiche estere delle
diverse civiltà del bacino mediterraneo. Da questa terrazza
naturale, i Bizantini, i primi di cui abbiamo notizia, controllavano
alcuni tratti stradali fondamentali che scavalcavano la dorsale
montuosa dei monti peloritani terminali del sistema appenninico
calabro-siculo.

Erymata (Remata) oggi Rometta (ME): veduta
nord-ovest.
E nella sua forma attuale, Rometta porta la radice del suo antico
nome, tramandato dagli scrittori del medioevo, R.m.t., fonema arabo
del greco-bizantino R(y)m(a)ta, a sua volta derivato dal verbo
greco-antico eruw, che
significa difesa, riparo. Ancora oggi, come al tempo della sua
fondazione, la svettante Rometta è pronta ad assicurare ai suoi
abitanti sicurezza e protezione poiché formata dalla natura e dalla
mano degli uomini per sostenere gli assalti alle sue mura o per
resistere ai più duri assedi.
Non sappiamo nulla sulla fondazione. Le evidenze archeologiche
emerse durante le campagne di scavo hanno identificato diverse aree
interessate da testimonianze materiali. In particolare, dentro la
cinta muraria, su una vasta fascia che si estende dalla via ex Roma
(oggi C. Terranova) fino alla linea delle mura perimetrali, è stato
rintracciato un livello archeologico di IV - III sec. a.C. Un’altra
area urbana, localizzata intorno al celebre edificio tardo antico,
conosciuto con il classico nome di Chiesa bizantina del S.
Salvatore, oggi più propensi a riconoscerlo come un battistero, è
occupata da una necropoli di epoca proto-bizantina e da ampie vasche
per la raccolta di acqua piovana scavate nella roccia.
Lungo tutta la parete rocciosa, ma anche in altre contrade adiacenti
la collina romettese, insistono numerose grotte. Tra queste assumono
rilievo di indagine quelle di contrada Sotto San Giovanni con
latomia ellenistica e chiesa basilicale a sette navate e,
proseguendo verso nord, si trovano gli ipogei altomedievali. Sul
vicino Monte Palostrago sono stati riconosciuti i resti di una
estesa necropoli a grotticelle artificiali dell’età del Ferro,
allargata e riutilizzata in età greca (IV a.C.) e poi bizantina.
Sull’area insiste la presenza di numeroso cocciame di età
preistorica e greca (IV – III a.C.).

L'archeologo Giacomo Scibona (in tenuta estiva): negli anni 60' del
secolo scorso condusse
delle campagne di scavi nel territorio romettese.
Sul vicino rilievo collinare della Motta, gli scavi, condotti negli
anni 60 del secolo scorso, hanno rilevato una successione
stratigrafica documentata riferita a una occupazione del sito sia in
età preistorica (rame, bronzo medio e tardo bronzo) che ellenistica
(strutture con ceramica di III a.C.). Stando ai rilievi
archeologici, in questi luoghi l’uomo vi ha messo le radici sin dal
neolitico, (facies di Stentinello), mentre nei documenti scritti
appare nell’alto medioevo, nelle fasi avanzate della conquista araba
della Sicilia. E qui si è massimamente d’accordo, ad identificare il
toponimo di epoca bizantina, Erymata o anche Rèmata, citato dalle
fonti, con l’odierno centro abitato di Rometta. Le tracce di un
passato vissuto alla grande, da protagonista dell’area peloritana,
Rometta li porta ancora oggi, con fatica seppur aggrediti, oltre che
dall’usura del tempo, dai terremoti e dall’incuria alla quale sono
state sottoposte per molto tempo. Oggi, queste testimonianze, mutili
e frammentarie, ci rivelano una grande storia sopita ed aprono una
porta verso una nuova conoscenza degli eventi che portarono questo
piccolo grande centro del versante messinese dei peloritani a vivere
da protagonista la maggior parte dei fatti storici di Sicilia.
L’epopea gloriosa di Bisanzio (877 - 965) - La prima comparsa
di Rometta nella storia si deve ad autori in lingua araba, vissuti
tra il X e il XIV secolo. Tra questi, i più prodighi di notizie,
sono al-Bannāʾ al-Shāmī al-Muqaddasī (947-?), Yāqūt al-Hamawī
(1179-1229), Ibn al-Athīr (1160-1233), an-Nuwayrī (1278-1332, Ibn
Khaldūn (1332-1406). Nelle loro opere si parla di Rometta come di
una città-castello facente parte dell’Impero dei Romani (Rūm)
d’Oriente al centro di diverse operazioni di guerra intraprese
dall’Islam, tra il 877 e il 965, per sottometterla e strapparla agli
odiati bizantini.
Nel 877 preparandosi alla conquista della maggiore città di Sicilia,
Siracusa, gli arabi fanno terra bruciata intorno alle roccaforti
bizantine del Val Demone che ancora resistono, tra cui Taormina e
Rometta in modo da non poter inviare eventuali aiuti a Siracusa.
Nell’estate 882, dopo aver inutilmente tentato di espugnare Rometta,
l’esercito arabo devasta il territorio circostante e rientra a
Palermo. Tre anni dopo si ripete un’ennesima operazione di
conquista. Anche questa volta non riuscita, e dopo aver distrutto
ogni cosa intorno alla rocca bizantina, le schiere saracene lasciano
quelle contrade, rovinate ma libere. Nel 902 un’imponente offensiva
è condotta dagli eserciti saraceni contro gli ultimi centri di
resistenza bizantina della Sicilia. Cadono Demenna, Aci e Taormina,
mentre Rometta è costretta a trattare la resa divenendo così
tributaria dell’emirato di Palermo. Ma nel 962, sia Rometta che
Taormina, rompono i patti di sottomissione e chiedono aiuti
all’Impero bizantino. Nel dicembre di quello stesso anno, la
popolazione di Taormina, assediata e priva di acqua, per la
distruzione dell’acquedotto esterno ad opera degli assedianti, si
arrende. Rimane solo Rometta.

L'Imperatore Niceforo affida ad Emanuele il
comando della spedizione in Sicilia (964).
Miniatura tratta dal Synopsis Historiarum di Joannis Skylitzes del
XII secolo,
manoscritto presso la Biblioteca Nacional de
Espana di Madrid.
Nell’estate
del 963 questa viene ripetutamente attaccata, e vista la tenace
resistenza della popolazione asserragliata dentro la città e le
pesanti perdite subite, gli arabi decidono per l’assedio ad
oltranza. Nel frattempo, il nuovo imperatore di Bisanzio,
Niceforo II Fokās (963-969), brillante generale e conquistatore
di Creta, invia in Sicilia un poderoso esercito formato da forti
contingenti di Armeni, Russi e Pauliciani , al comando del giovane
nipote Manuele Fokās (Fig. 2) sostenuto da una forte squadra
navale guidata da Niceta. Nei pressi della roccaforte assediata, tra
la costa tirrenica e i passi peloritani, il 24 ottobre del 964, i
due eserciti si scontrano in una sanguinosa battaglia, dalla quale i
saraceni ne escono vittoriosi. Così, in Calabria, in quei giorni, un
rattristato Nilo di Rossano, monaco italo-greco, appresa la notizia,
annota: «nell’anno del mondo 6473 fu sconfitto l’esercito del
patrizio Manuele alle remata (Rometta), e le stesse remata furono
prese e vi fu inoltre grande strage». Stessa sorte subisce la flotta
bizantina nelle acque dello Stretto dove l’ammiraglio Niceta è
catturato e tradotto in Tunisia. Il 5 maggio del 965, logorati da
ventuno mesi di duro assedio e devastati dalla mancanza di cibo, i
difensori di Rometta inviano fuori
[…] le bocche inutili: mille della povera gente,
com’è sembra, tra vecchi, donne e fanciulli. Ibn-‘Ammâr, invece di
respingerli nella fortezza e affrettar la dedizione di quella, li
accolse e mandò in Palermo; ma fu crudele coi rimanenti. Fatti pelle
ed ossa, tuttavia combattevano, quando un giorno Ibn-‘Ammâr
apparecchia le scale, dà l’assalto, lo protrae fino a notte; e
allora una mano dei suoi salì su le agognate mura di Rometta.
Passati a fil di spada gli uomini, saccheggiata la città, e fattovi
grande bottino. Partendo dopo un anno e mezzo da’ selvaggi luoghi
illustrati con tanto sangue, lasciò nella rocca presidio e abitatori
musulmani .
Oltre agli autori in lingua araba, di Rometta e dell’infelice esito
dell’intervento siciliano dell’imperatore Niceforo terminato con la
Battaglia e la espugnazione, parlano altre fonti preziose, quali i
Codici: gr. XX Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae» del X sec.;
il gr. Vaticano 1812 sempre del X sec.; il gr. Parigino 920 del X-XI
sec.; il gr. Vaticano 2072 del X sec.; il Cod. ar. di Cambridge
compilato tra l’XI e il XII sec.; il gr. Graecus Matritensis Ioannis
Skylitzes del XII sec. e Leone Diacono intorno al decimo secolo.
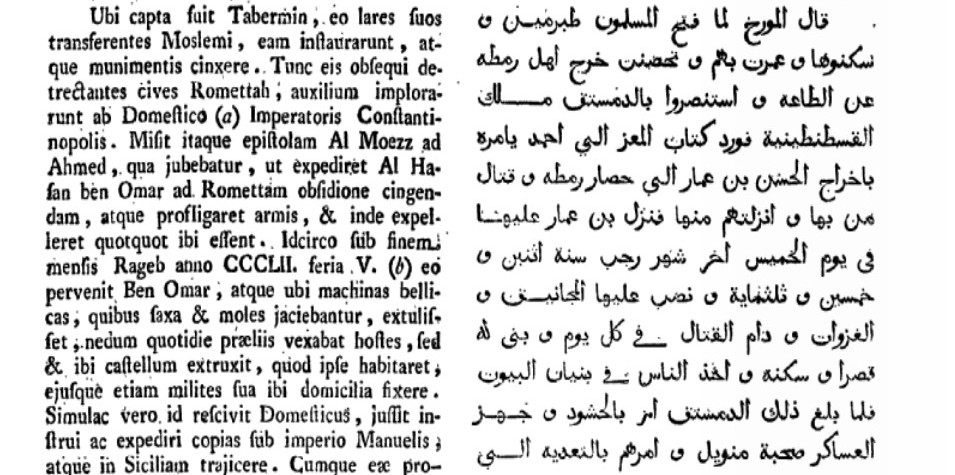
Rerum
arabicarum quae ad historiam Siculam spectant ampla collectio ,
opera
e studio Rosario Gregorio, 1790.
La Rometta araba diventa un nodo militare strategico, una roccaforte
«Qal’at R(y)mta», dove trova quartiere una nutrita
guarnigione con lo scopo di vigilare su Messina e sui passi di
montagna. Nei tre anni successivi alla conquista, gli arabi
ristrutturano le opere difensive della rocca. Opere che verranno
smantellate nel 969 nell’ambito di nuovi trattati di distensione tra
l’Impero bizantino e il Califfato magrebino. Però, tra la fine del
976 e gl’inizi dell’anno successivo, venendo meno gli accordi con
Costantinopoli, gli arabi ricostruiscono ciò che avevano diroccato e
cioè, la cortina muraria e le altre strutture militari e Rometta
ritorna ad essere operativa militarmente. Tutto questo dopo che
Messina, per l’ennesima volta, nel maggio del 976, è stata assaltata
da una flotta bizantina proveniente dai porti calabresi e
immediatamente liberata dall’esercito arabo che si era radunato a
Rometta e da qui calato su Messina dai passi montani.
La spedizione di Giorgio Maniace - Nel 1038, i bizantini, mai
rassegnati della perdita della Sicilia, organizzano una nuova
campagna militare affidata al generale, Giorgio Maniace. Sbarcato a
Messina, presso capo Peloro, con un esercito composto da Russi,
Scandinavi (Vichinghi), Italiani di Puglia e di Calabria e con
un contingente di cavalieri normanni inviatogli dal principe di
Salerno, viene subito affrontato dalla guarnigione della città che,
uscita fuori dalle mura, impavida si scaglia sulle schiere
avversarie. Grazie soprattutto all’intervento risolutivo dei
cavalieri normanni, guidati da Guglielmo d’Altavilla, gli arabi
vengono annientati consegnando a Maniace la città dello Stretto. Le
fonti ci fanno intendere, come ipotizza l’Amari , che questo primo
scontro sia avvenuto fra avanguardie e che il grosso dell’esercito
arabo sia posizionato in realtà sui colli peloritani, proprio vicino
alla loro base principale, Rometta, in posizione dominante, pronto a
rigettare in mare gli invasori. Maniace li affronta con audacia,
appiccando una sanguinosa battaglia in prossimità dei passi montani
e li sbaraglia: «[…]in Siciliam appulit Georgius Maniaces […]
conflictum ad locum cui Remata nomen, et victa carthaginenses,
eorumque tanta edita strages ut sanguine profluens inundaret» .
Lo scontro con molta probabilità si svolge presso il passo di Croce
Cumia per allargarsi subito su tutta la dorsale peloritana
circonstante.
Anche se nulla ci dicono gli scritti sulle sorti di Rometta, è
facile ipotizzare che questa sia stata occupata dalle truppe
bizantine e che il suo nome rientri tra il novero dei tredici
castelli e città temporaneamente conquistati dalla breve avventura
siciliana di Giorgio Maniace. Sospettato di tradimento, il generale
è rimosso dal comando proprio mentre gli Arabi ritornano
vittoriosamente alla controffensiva annullando totalmente le
conquiste tanto faticosamente ottenute nei due anni precedenti.
L’impresa militare di Maniace è entrata a far parte delle saghe
nordiche europee attraverso le gesta giovanili di Harald Hardrada
(lo Spietato), fondatore della città di Oslo, che dal 1046 al 1066
diventerà re di Norvegia (Harald III Sigurdsson della dinastia
Hårfagreætten), che secondo la leggenda combatte nelle file
dell’esercito bizantino assieme ad altri conterranei nella battaglia
dei passi peloritani e di conseguenza entra vittorioso nella
roccaforte romettese, a fianco del Maniace e del normanno
Guglielmo “braccio di ferro”. Harald viene considerato dai
Norvegesi come l’ultimo vero vichingo che si possa fregiare di
questo “prestigioso” e nello stesso tempo “terribile” nome.

Harald Hardrada, Re di Norvegia, ultimo Vichingo, combatté nelle
file dell'esercito bizantino
al comando di Giorgio Maniace nella battaglia dei peloritani nei
pressi di Rometta (1038)
L’invasione dei Normanni. - Nel 1060 i normanni, guidati da
Roberto d’Altavilla, detto il Guiscardo, con la conquista di Reggio
completano la loro impresa che li vede, adesso, acerrimi nemici dei
bizantini mentre, prima molti dei loro padri avevano militato nelle
file degli eserciti imperiali come mercenari. La loro corsa non si
ferma sulle rive calabresi dello stretto, ma continua oltre: la
Sicilia, con le sue ricchezze è a portata di mano. Il fratello
minore del Guiscardo, Ruggero, abile cavaliere, invia un manipolo di
guerrieri che sbarca tra Capo Peloro e Milazzo. Vuole raccogliere
notizie sulla consistenza dei soldati saraceni presenti in zona, gli
stessi che, in caso di un eventuale attacco a Messina proveniente
dal mare, avrebbero potuto accorrere in difesa di questa. Il giorno
dopo, nei pressi di Rometta, i normanni vengono intercettati da un
grosso gruppo di cavalieri nemici. Sono costretti a riguadagnare il
mare e fare rientro a Reggio.
Agli inizi del 1061, a Mileto, Ruggero è raggiunto da emissari del
governatore arabo di Catania, Ibn ath-Thumnah per la richiesta di un
patto di belligeranza contro l’emiro di Sicilia, Ibn al_Hawwas. Si
tratta di una ennesima guerra civile tra arabi di Sicilia che
contraddistinguerà gli ultimi decenni del dominio musulmano
sull’isola. Ruggero accetta e, in fretta, raccoglie un migliaio di
uomini, fra cavalieri e fanti che, imbarcati, fa approdare nei
pressi di Milazzo, la quale riesce ad avere senza colpo ferire; così
come Rometta in quanto i capi militari delle due piazze si
professano fedeli ad Ibn ath-Thumnah. Non si tratta di un vero e
proprio piano d’invasione, ma di una massiccia razzia perpetrata ai
danni di un territorio nemico fedele all’emiro dell’isola. Questo è
quello che si vuol far credere, mente in realtà, è intenzione dei
Normanni costituire una testa di ponte per un successivo massiccio
sbarco. Gli arabi di stanza a Messina reagiscono inviando una
numerosa formazione di cavalleria sulla spiaggia a Capo Peloro, dove
il bestiame razziato stava per essere stivato sulle navi per il
traghettamento sulla sponda opposta. I cavalieri saraceni cadono in
una morsa che non dà loro alcuna via di scampo. I normanni, fidando
che ormai Messina si trova pressoché indifesa, si avviano per dare
l’assalto alle mura. Ma accadde l’impensabile. La popolazione di
Messina, diversamente da come si pensava, accorre in armi sulle mura
accanto ai pochi soldati rimasti per difendere le proprie case dai
pirati-normanni. La reazione dei messinesi costringe gli invasori ad
imbarcarsi e riparare a Reggio incalzati da una squadra navale
saracena, mentre l’alleato Ibn ath-Thumnah senza alcun ritegno si è
dato ad una fuga precipitosa verso Catania.

Cavalieri normanni - scene tratte dall'arazzo di
Bayeux (Francia)
A maggio di quello stesso anno, un nuovo e più numeroso corpo di
spedizione salpa da Reggio e, protetto dall’oscurità, attraversa le
acque dello Stretto a sud di Messina, per sbarcare uomini e cavalli
presso l’odierna Tremestieri. Questa volta Messina viene presa di
sorpresa in quanto i saraceni vigilano in armi tutta la spiaggia a
nord, dove è avvenuto il primo tentativo sventato. La città viene
saccheggiata e i normanni si rendono autori di veri e propri atti di
violenza sulla popolazione. Dopo aver riparato le mura e rinforzate
le difese di Messina, i normanni si dirigono su Rometta, dove è
segnalata una forte presenza di soldati nemici, fedeli al legittimo
signore di Sicilia. I normanni e gli uomini dell’alleato Ibn
ath-Thumnah pongono il campo nei pressi della città-fortificata per
pianificare gli assalti alle mura. Ma il governatore (qaid) arabo
della piazzaforte apre le porte ed esce con i suoi dignitari e,
recandosi nel campo avversario, giura fedeltà, questa volta
apertamente, sul Corano ai nuovi arrivati .
I castelli normanni della piana di Milazzo. Ancor prima di un
vero e proprio assetto politico-amministrativo che avrebbe portato
ad una gestione ordinata ed efficiente del vasto territorio,
compreso tra Messina e capo Tindari, e nell’attesa della conclusione
della campagna militare per l’occupazione definitiva della Sicilia,
Ruggero il Gran Conte affida la difesa e la protezione dell’area ai
due centri abitati che possiedono delle fortificazioni «[…]
castellorum Rimeta, Melacium» e sono più rilevanti per dimensione,
densità di popolazione e status legale.

Rometta: reliquario a cofanetto in osso inciso
intagliato e dipinto su anima in legno (sec. XII)
Per tutta l’area della cuspide nord-orientale, compreso il piano
milazzese, possiamo ipotizzare un’attività di reimpiego delle opere
prettamente militari esistenti, mentre l’attività edilizia vera e
propria, si manifesta in massima parte per chiese ed abitazioni
civili , conseguenze del rifiorire demografico ad opera di gente
proveniente dalla penisola italica all’indomani stesso dello sbarco
degli Altavilla, con una forte preponderanza di immigrati calabresi.
Si tratta di una graduale espansione urbanistica di nuovi siti ma
anche di vecchi centri esistenti: tutti profondamente legati allo
sfruttamento agricolo del fertilissimo suolo . Il numero di casali,
rahal, choria, pagus quali Gaidara, Papalardo, Mesolario, Capogio,
Monastria, Kondou, Milici, Solaria, Protonotaro, Catafi, Aghiosmenna,
Apostolo Andrea.
Per la stabilità normanna serve un’adeguata organizzazione economica
e militare di tutta la regione in generale, ed in particolare
dell’entroterra tirrenico del messinese, considerato quest’ultimo di
interesse strategico per un efficace controllo di Messina già
definita «quasi clavem Siciliae» .

Rometta: reliquario a cofanetto sec. XII
(particolare)
La testimonianza di Idrīsī (1099-1165) di settant’anni dopo l’inizio
della riconquista alla cristianità latina, evidenza l’attività di
assestamento dell’area:
«Milas castello spazioso è paese grasso e forte rocca, paese de
più belli. Ha buoni campi da seminare, copiose acque perenni e
parecchie pescherie del tonno grande» .
Ed ancora:
«da Messina alla rocca di R.mtah corrono nove miglia e da questa
a Munt Dafurt (Monforte) per mezzogiorno, quattro miglia. Da Munt
Dafurt a Milazzo quindici miglia per tramontana» .
E dall’arabo Yaqut,
«R.mtah è nome straniero d’un castello forte nell’isola di
Sicilia. Essa è lontana dal mare, sopra un monte; in essa sono pozzi
d’acqua. La conquistò al-Hasan nel 965 e vi si domiciliarono i
musulmani: la dovettero assediare per ventuno mesi» .
Per il consolidamento dell’amministrazione normanna diventa parte
attiva la presenza del clero greco e latino . Il primo, molto
numeroso, è rappresentato in larga maggioranza da monaci dell’ordine
dei Basiliani, saldi ed attivi in cenobi, laure, ed eremi, ben
inseriti nel tessuto sociale e sparsi per ogni dove in tutta l’area
a maggioranza grecofona, in molti casi preesistenti all’occupazione
araba e sopravvissuti all’intemperie della diversa fede. Anche la
galoppante riorganizzazione della chiesa latina partecipa
all’affermazione dell’ordine normanno e occidentale. E le due terre
restano anche per gli anni successivi gli unici centri abitati di
rilievo che nella Piana costituiscono il territorio della diocesi
peloritana, così come indicano le fonti vaticane nelle Bolle
Concistoriali degli anni 1151, 1166, 1198, 1216 e 1236 indirizzate
ai vari vescovi messinesi.

Rometta: Croce astile del XII sec. - lamina in
rame sbalzato, inciso e in parte
dorato su anima in legno (cm. 44 x 32)
Seppur nelle intenzioni di Roberto il Guiscardo tutto il Val Demone,
o perlomeno una vasta porzione debba rimanere proprietà demaniale ,
Ruggero prendendo le redini del governo, inizia ad estendere anche a quest’area la prassi del trasferimento di alcuni poteri del dominus
attraverso la delega dell’investitura a persone di fiducia e
dell’entourage dell’Altavilla ai quali affida la parziale autorità
su persone, beni e cose, entro i confini fisici della concessione.
Con l’avvio del processo di feudalizzazione si stravolgono confini e
territori modificando l’impostazione censuaria delle antiche
parcellizzazioni fondiarie, in massima parte di eredità romana,
dando vita nelle campagne a nuove indicizzazioni immobiliari,
formati sia da semplici aree disabitate e quindi, da bonificare, ma
anche da modesti agglomerati rurali, da villaggi e da casali,
assieme alle loro pertinenze. Nonostante ciò, la maggior parte delle
aree agricole, comprese le unità abitative della Piana, rimangono
nella disponibilità di Ruggero e dei suoi successori.
Anche quando più tardi, verrà esteso capillarmente il sistema delle
concessioni feudali (svevi, aragonesi), il Planum Milatium
presenterà pur sempre una forte concentrazione di aree e terre
demaniali rispetto ad altre regioni del Regnum Siciliae. Infatti
sono demaniali, quindi della corte regia, vaste estensioni di aree
boschive, seminativi, pascoli oltre a casali, quali Solarìa e
Protonotaro, e terre, quest’ultime divenute in età moderna quasi
tutte città con l’esborso di un forte donativo in moneta contante
versata nelle casse della monarchia spagnola. Tra queste, Rometta
(da terra a città nel 1648), S. Lucia del Mela (1621), Castroreale
(1621), Milazzo (1621), Puzo di Goto (1639) e Monforte che avrà
un’appartenenza al demanio di breve durata poiché diverrà
stabilmente governata dal diritto feudale . A Rometta nel novembre
del 1096 è presente un funzionario dell’amministrazione normanna, il
Vicecomite di Ramettae, certo Leone Catananchi impegnato a dirimere
«udicis faciens pro Domino Rogerio Comite» una vertenza sorta tra
abitanti del luogo . Tra i fatti d’armi documentati quello della
rivolta di Messina contro il cancelliere del minore Guglielmo II, e
arcivescovo di Palermo, Stefano des Retrous, conte di Perche, quando
i rivoltosi, tra il 1168-69 si impossessano dei due centri che
controllano le strade per la città dello stretto: Taormina e
Rometta. In quest’ultima riescono a corrompere il funzionario reale
«[…] Messanenses aditus viarum obstruerent, primo Rimetulam (Rimetta) castellum fortissimum, occuparunt, castellani fide
promissis facile precorrupta».
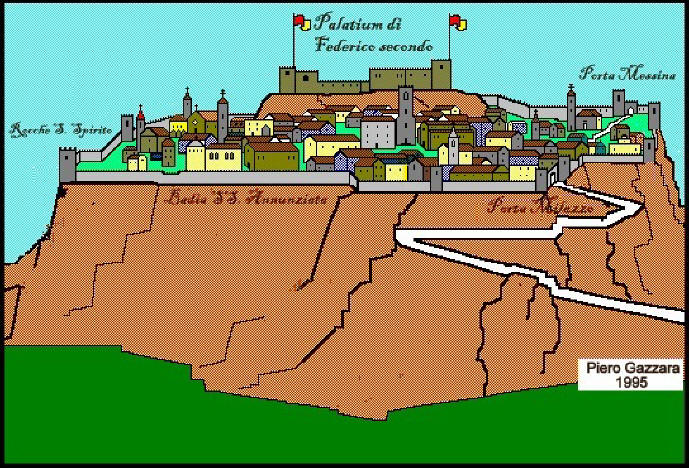
La Terra fortificata di Rometta nel XV - XVI sec. (disegno
ricostruttivo).
Dagli svevi agli aragonesi: castra exempta. La peculiarità di
città murata, fortissima nella difesa, perdura sotto
l’amministrazione sveva del Regno. Nel 1239 il castrum ossia tutto
l’apparato di fortificazioni del borgo murato di «Rainecta» (Ramecta)
situato in «Sicilie citra flumen Salsum» è operativo e rientra nel
progetto che l’Imperatore Federico II Svevia (1194 - 1250) elabora
per creare una prima rete di castelli (castra exempta) in grado di
costituire una solida difesa del Regno dai nemici esterni e interni.
E tra le strutture militari presenti nella piana a fianco di «Melacium»
(Milazzo) e di Rometta compare anche il castrum di «Monsfortis» (Monforte
San Giorgio.) . Tutti i castelli rientranti tra quelli individuati
nella lista degli exempta dipendono direttamente dall’Imperatore che
ne dispone tramite i Provisores Castrorum. Questi funzionari
sovrintendono alla manutenzione delle fortificazioni, il cui costo
grava sui bilanci delle città stesse, e ai rifornimenti di armi ed
ufficiali. La nomina del castellano, comandante del castrum, rimane
tra le prerogative regie.
Identica disposizione militare è sancita dall’amministrazione
angioina nel maggio del 1274. In quell’anno, Re Carlo I emana lo
Statutum Castrorum Sicilie que custodiuntur per Curiam cum numero
Castellanorum, con il quale si assegnano i militari professionisti
(regolari) di servizio nelle strutture militari del Regno, mentre è
da ricordare che, com’è consuetudine dell’epoca, spetti agli uomini
del luogo il normale servizio di vigilanza delle mura e delle opere
avanzate nel territorio, quali torri e torrette. A Rametta viene
assegnato un uomo d’armi facente funzioni di congierge il quale ha
il compito fino a che non sia sollevato da un ufficiale di grado
superiore, di sovrintendere a tutte le normali attività militari del
castrum. L’entità dei soldati regolari di guarnigione assegnati ad
ogni singola struttura demaniale ci indica che il numero della
popolazione maschile residente in Rometta, in quell’epoca, sia
bastevole per attendere alle principali funzioni di sorveglianza e
di prima difesa, soprattutto come balestrieri, lancieri, scudati e
arcieri, contro minacce improvvise, considerate anche le
potenzialità strutturali difensive possedute dalle fortificazioni
del Castrum romettese. Il 26 gennaio 1283, Ind. XI, Re Pietro
richiede per iscritto a Bajuolo e Giudici di Rometta, come ad altri
centri abitati, di inviare al campo dell’esercito reale gente
armata: nel nostro caso sono sei arcieri, «Ramectae pro archeriis
sex datum» .
Infatti, la specifica assegnazione della forza militare prevista
dallo Statutum, diversa per ogni singolo centro di difesa del Regnum,
è da intendersi strettamente in rapporto alla specificità strategica
che ciascun sito occupa nell’ambito geografico di riferimento. La
posizione particolare del borgo murato di Rometta, abbastanza
isolato dal contesto fisico circonstante, non permette ad un
esercito ostile di utilizzare le normali macchine ossidionali, sia
quelle a getto che di sfondamento, quali torri mobili, mangani,
arieti, trabocchi, etc. che generalmente vengono impiegate contro
siti fortificati di pianura (Milazzo) o di modesta entità (Monforte).
La stessa situazione si mantiene nelle successive ripartizioni del
Giustizierato della Sicilia orientale del 1268 e del 1276 e rimane
sostanzialmente invariata per tutta la durata del regno di Carlo d’Angiò.
Il 3 aprile 1281, appena un anno prima dello scoppio della rivolta
dei Vespri, Radulfo de Gorley viene nominato Provisorem castrorum
Sicilie. L’assetto svevo ed angioino si evidenzia inizialmente,
anche per l’età aragonese. Pietro III d’Aragona nel 1282, nella
marcia di avvicinamento a Messina assediata da Carlo I, arrivato a
Randazzo seguendo la via interna delle montagne, preferisce valicare
la catena montuosa tagliando in direzione di Argimustus , nei pressi
di Montalbano, e di Furnari anziché proseguire verso nord sul
tracciato dell’antico Dromo. Il suo esercito, oltre a una buona
presenza di cavalleria, fa affidamento sulla forza della fanteria
degli almogaveri , più idonei a combattere su terreni accidentati
che in pianura, il Re aragonese decide di marciare in valle Melacii
e di calare su Messina dai passi della dorsale peloritana, vicini
alla città, sfruttando appieno le qualità del proprio esercito.
Questa scelta tattica ottiene subito due esiti importanti: porta
l’esercito aragonese al controllo del piano milazzese e costringe
Carlo a ritirarsi in Calabria ancor prima dell’arrivo di Re Pietro a
Messina.

Rometta: Porta Milazzo, (detta anche Borbonia e
Terra) con i resti del Torrione Saraceno
Dilungandosi negli anni la guerra del Vespro, la politica aragonese
di Federico III stravolge radicalmente l’assetto non solo difensivo
della Piana milazzese ma anche quello insediativo. Le numerose e
sanguinose incursioni degli eserciti del Re di Napoli, Roberto d’Angiò
contro l’entroterra messinese, nel tentativo di privare la stessa
Messina della sua fonte principale di rifornimenti alimentari, hanno
messo a dura prova tutta la vasta regione con devastazioni e
saccheggi e tutte le volte le schiere nemiche sono state ricacciate
con ingenti perdite. É ormai evidente che il solo castello di
Milazzo non sia in grado di sostenere l’urto delle armi angioine,
mentre i castelli di Monforte e Rometta si trovano lontani e a loro
volta spesso sotto attacco. Così Federico decide di potenziare il
dispositivo di difesa territoriale creando due nuovi castrum,
Castroreale e l’odierna S. Lucia del Mela, dove costringe gli
abitanti dei casali vicini ad abitarvi. Fortifica l’abitato di
Monforte raccogliendolo entro una solida cinta muraria e ristorando
il vecchio fortilizio bizantino di Monte Marra (m. 377). Potenzia
con nuove opere fortificate il sito di Montalbano Elicona e conferma
con atto scritto la demanialità di Rometta.
Questo sistema, pensato
per il controllo della vasta regione, ricca di risorse
indispensabili, quali quelle agricole, forestali e zootecniche, si
protrae sino alle soglie dell’età moderna contribuendo allo sviluppo
demografico ed urbanistico. Agli inizi del XIV sec. iniziano ad
essere documentati in Sicilia le nuove armi che utilizzano la
polvere da sparo che rivoluzionano profondamente l’architettura dei
Castelli. A Rometta vengono posizionati sugli spalti del
Castello-Forte di Porta Milazzo alcune bocche da fuoco puntati sulla
collina di Portaro e sulla piccola vallata antistante, altri presso
il Castello-Forte di Porta Messina. In questo periodo sono attestati
lavori di rifacimento e di adattamenti al sistema difensivo murario
, soprattutto nei due Castelli a difesa delle porte e nel Palatium.
Quest’ultimo costituisce il mastio centrale, cuore di ogni estrema
difesa. Sorge sul punto più alto, su un limitato rilievo, avvolto da
una cortina muraria, all’interno della quale si ergono due corpi
abitativi, distinti e separati .
Durante il lungo regno di Federico III, Re di Sicilia (1296-1337) il
«castrum vel Fortilicium Terre Ramecte» partecipa attivamente alle
operazioni belliche resistendo ai tentativi di conquista da parte
angioina. Nell’estate del 1352 Re Ludovico vi soggiorna con una
parte del suo seguito al sicuro delle mura di Rometta .
Con la Spagna. Nella rivolta di Messina del 1674 -1678,
Rometta è trasformata in un grande accampamento militare, da dove
l’esercito spagnolo parte per tentare di sfondare la resistenza dei
rivoltosi, schierati a difesa dei passi montani che aprono la strada
su Messina. Le contrade di San Cono e di Bagni diventano un grande
accampamento, dove da Milazzo, quartier generale e base di
smistamento delle operazioni militari, affluiscono armi, uomini e
vettovaglie, all’indomani stesso dello scoppio delle ostilità. Da
Rometta, nell’agosto del 1674, parte un numeroso contingente di
soldati che, presso il passo di Lombardello (1050 m.), posto sulla
dorsale peloritana, che separa Messina dal suo entroterra tirrenico,
è affrontato dalle milizie messinesi. Lo scontro si protrae per
alcune ore nei quali tutti i tentativi delle truppe spagnole,
composte oltre che da siciliani, da calabresi, milanesi e
napoletani, sono respinti dai rivoltosi. Alla fine la fanteria
spagnola si ritira dentro le mura di Rometta, nonostante l’iniziale
ritrosia della popolazione manifestata nei confronti della truppa.
Con i diversi tentativi, finiti male, di conquistare le cime dei
colli, i generali spagnoli decidono di consolidare l’accerchiamento
di Messina, unendo ai capisaldi di Gesso, Rometta e Monforte, anche
i vari castelli, palazzi fortificati e casali feudali del
territorio: Villafranca Tirrena, Spadafora, S. Martino, Venetico,
Roccavaldina e Gualtieri Sicaminò. Terminata la rivolta, i Giurati
di Rometta vista la disastrosa situazione economica in cui versa la
loro
città e tutto il territorio, messo in ginocchio da quattro anni di
guerra, avanzano l’istanza al Sovrano spagnolo di poter sospendere
il pagamento della gabella di 14 tarì su ogni salma di frumento
proveniente dal caricatoio di Milazzo: l’imposta è stata introdotta
per le spese (partecipate da tutti i paesi del circondario)
occorrenti al rafforzamento delle fortificazioni esistenti nella
stessa Milazzo .
Nel 1719, ad appena poco più di quarant’anni dopo i fatti della
rivolta, Rometta ritorna ad essere nuovamente al centro di fatti di
guerra. Questa volta, per tutto il settembre 1719 diventa la base
dell’esercito spagnolo al comando di D. Giovan Francesco de Bette,
Marchese de Lede. Con i trattati internazionali di Utrecht (1713) e
di Rastatt (1714) il Regno di Sicilia è passato sotto il dominio del
Duca di Savoia, Vittorio Amedeo II che assume così il titolo di Re.
Nel 1718 la Corona spagnola decide di riprendersi l’isola, ma il
corpo di spedizione inviato per la conquista, dopo aver occupato
tutta la Sicilia, rimane bloccato a Milazzo che resiste ad un duro
assedio, da ottobre 1718 al maggio successivo. Dopo la sanguinosa
battaglia di Francavilla del 20 giugno 1719, la controffensiva
alleata punta su Messina,

Rometta: mappa delle vie montane in dotazione del corpo di
spedizione spagnolo
al comando del marchese di Lede (1718).
dove il 6 agosto dello
stesso anno, dopo durissimi attacchi, si arrende il castello Gonzaga
e gli spagnoli si ritirano nella Cittadella. La difficile situazione
spinge il Marchese di Lede a lasciare il suo campo trincerato di
Francavilla e, nell’attesa di soccorrere la cittadella, pone il
campo a Rometta. Tra le carte del suo stato maggiore, una in
particolare traccia le fortificazioni di Rometta e le strade
mulattiere dei due passi montani (Fig.3) di Croce Cumia e di
Lombardello-Santo Stefano Briga , attraverso i quali, nelle
intenzioni del marchese di Lede, deve affluire la sua armata di 15
mila soldati per venire in aiuto dei suoi uomini, asserragliati
nella Cittadella e nel Forte SS. Salvatore. Ma mentre il Marchese di
Lede, al sicuro tra le mura di Rometta tergiversa sull’attacco, a
Messina la situazione precipita sempre di più. Già il 9 agosto, la
città, stretta dalla fame, si è arresa e i messinesi hanno
riconosciuto come proprio sovrano, l’Imperatore Carlo VI. Dopo pochi
giorni, anche le guarnigioni spagnole delle fortezze di Matagrifoni
e Castellaccio, tempestate dal fuoco nemico sono state costrette
alla resa. Solo la Cittadella, con il vicino Forte del SS.
Salvatore, sotto il tiro delle artiglierie austriache del Conte di
Mercy, resiste con difficoltà. Tra il 22 settembre e il 2 ottobre,
gli spagnoli lasciano definitivamente il campo di Rometta verso
l’interno della Sicilia e, da lì a poco, la Cittadella di Messina si
arrende. La pace di Cambrai del 1720 pone fine alle ostilità.
Dagli Inglesi al pericolo francese post-unitario.
Per tutta la durata delle guerre napoleoniche, l’Inghilterra
mantiene in Sicilia un corpo di venti mila soldati pronto ad
intervenire per sventare un’invasione francese proveniente dalla
Calabria. Quasi tutti gli Inglesi si trovano schierati nella parte
orientale dell’isola. Nei piani di un possibile attacco nemico,
Rometta riveste un ruolo nodale, dove, in caso di successo dello
sbarco nemico, gli Inglesi si possano ritirare nell’attesa di
sferrare una controffensiva su Messina occupata dal nemico. In tale
evenienza i genieri inglesi allargano la strada mulattiera
Spadafora-San Martino-Torretta rendendola carrozzabile: da questa
arteria devono affluire i rinforzi con i rifornimenti. Ristorano le
mura di cinta, rovinate dal terremoto del 1783, in special modo i
tratti nei pressi delle due porte d’accesso. Costruiscono delle
garitte sulle mura e al di fuori per mantenere numerose sentinelle e
punti d’osservazione, soprattutto rivolti verso il Golfo di Milazzo,
altro possibile obiettivo di un eventuale sbarco francese. A tal
fine riutilizzano le due torri medievali in contrada Torretta,
sovrastanti uno stretto passaggio della strada che porta alla piana
di Milazzo. Un dipinto inglese (Fig. 4) dell’epoca raffigura Rometta
nel tratto esposto ad ovest, cinta da mura ed isolata in mezzo ad un
paesaggio montuoso .
Nel 1890, nell’ambito del vasto programma di opere di difese di
Messina ed a seguito dell’ispezione del generale Genè e della
commissione militare, preposta alla pianificazione delle opere
militari da opporre ad una possibile invasione della Repubblica
Francese, dopo i fatti di Tunisi del 1881, si decide di migliorare
le vie montane per assicurare le comunicazioni fra Rometta e la
linea trincerata della dorsale dei Peloritani. Inoltre, si
stabilisce che in caso di un eventuale attacco nemico, con sbarco
sulle coste tirreniche, sia meglio posizionare sul monte Palostrago
una batteria di obici per contrastare l’avanzata ostile verso
Messina. Alla fine si opta per un punto di osservazione che trova
ospitalità nei ruderi di una chiesetta sconsacrata che viene
ristrutturata per alloggiare i militari.

Rometta nel 1810 in una stampa pubblicata da John Harding.
Londra 1815.
Le fortificazioni.
Rometta sorge sulla cima di una rupe a 540 m sul livello del mare,
circondata da pareti scoscese, che l’hanno reso isolata dal contesto
orografico circonstante. E qui prendiamo a prestito le parole di un
viaggiatore irlandese, ufficiale del corpo di spedizione inglese in
Sicilia al tempo della guerra antinapoleonica che tra il 1810-11
girò per sei mesi gran parte dell’isola:
Anche se Rometta è circondata da diverse colline, queste sono così
lontane che è quasi impossibile portare in cima i cannoni (per
tirare alle mura), per questo io considero, Rometta, quasi
inespugnabile. Ci sono centinaia di situazioni simili in Sicilia: e
la migliore difesa del nostro esercito (inglese), se agendo
all'unisono, sfiderebbe qualsiasi forza d'invasione: tale è la forza
naturale di molte posizioni in questa singolare isola .
Chiunque sia stato il primo fondatore a scegliere questo sito non
possiamo dubitare che abbia avuto una priorità assoluta: sicurezza.
E qui ci si trova di fronte ad un luogo adatto ad assolvere
egregiamente a questa funzione. Per renderla inespugnabile «bastava
- come afferma Giuseppe Agnello - tirare (costruire) un semplice
muro di sbarramento lungo il ciglione per frustare ogni tentativo di
assalto, anche se sferrato da eserciti agguerriti ed aggressivi.
Rometta – prosegue Giuseppe Agnello – si leva come naturale baluardo
isolato da precipizi e impervie vallate» .

Sullo sfondo il versante nord della collina di
Rometta con il borgo di Uliveto in primo piano.
Di seguito ci piace indicare alcune delle caratteristiche che hanno
contribuito a creare una parte della storia di Rometta:
- sito su un vasto terrazzamento elevato in cima ad una collina
rocciosa;
- sino agli inizi della prima metà del XIX sec. difficile da
raggiungerla in quanto fornita solo di stretti sentieri alpestri;
- la sommità era divisa in due parti di cui, una urbanizzata e
l’altra formata da terreni agricoli (Via Roma, quartiere Cappuccini)
che in caso di assedi poteva fornire generi alimentari di prima
necessità;
- presenza di acqua sorgiva attraverso i pozzi scavati ad una
profondità di appena tre metri esistenti sulla cima della collina e
quindi entro la cortina difensiva;
- numerose cisterne artificiali per la raccolta di acqua piovana;
- la collina era isolata e lontana da altri rilievi a tal punto da
non permettere di essere raggiunta da armi offensive che potessero
battere le mura di cinta o da essere sottoposta a bombardamenti sul
centro abitato. Prerogativa durata sino alla seconda metà del 1800.
- crocevia di due strade mulattiere di importanza strategica che
servivano a scavalcare la dorsale dei monti peloritani e raggiungere
Milazzo e la piana.

Rometta: Porta Messina (detta anche Castello,
Marina)
Tutto il perimetro dell’abitato è cinto, sin dall’epoca bizantina,
di mura . I resti di fondamenta della cinta sono stati rintracciati
sulla parte nord, dove non c’è stata attività edilizia, in quanto
l’area era utilizzata per attività agricola, mentre sul lato
meridionale sono state per un buon tratto inglobate nelle abitazioni
civili, già a partire dai primi del novecento per proseguire sino a
tempi recenti . Sul diffuso abusivismo perpetrato, nei decenni
passati, ai danni degli immobili demaniali, quali mura di cinta,
torri e porte, e su quelli religiosi di Rometta, una piccolissima
parte di questi illeciti urbanistici è testimoniata dai diversi
documenti depositati presso l’Archivio della Soprintendenza di
Messina e tra questi risaltano, ad esempio:
- costruzione abusiva del 1963 addossata alla torre dei saraceni
(torrione di Porta Milazzo) ;
- vertenza per una costruzione abusiva del 1915 addossata alla
chiesa bizantina .
Dell’esistenza di torri di cinta che, ad intervallo si innalzano
lungo il perimetro, strutturalmente necessarie per rinforzare
staticamente una così lunga estensione, ma anche per permettere una
difesa efficace nei tratti di eccessiva angolarità, abbiamo tracce
che ci hanno portato ad individuarne solo cinque. La prima a pianta
quadrata si eleva a strapiombo sul precipizio nel settore di ponente
e si riferiva al Castello-Forte costruito a difesa di Porta Messina.
Una seconda torre è testimoniata da una stampa del 1810 dove si
riconosce una torre che inglobava la porta stessa. La terza è
ancora visibile: il
torrione circolare, detto anche torre saracena, che affianca l’altra
Porta, quella denominata Milazzo. La quarta torre risulta
incorporata in delle abitazioni civili sul versante sud-ovest
individuata dallo Scibona negli anni 60 del secolo scorso. L’ultima
era localizzata ai lati dell’odierna via Federico II di Svevia,
contrada Rocche: di forma circolare era costruita nella stessa area
dove oggi vi è il belvedere di San Giuseppe .
L’apparato di difesa è integrato con le strade d’accesso
d’avvicinamento alle due Porte, da sempre punti deboli e vulnerabili
in un sistema fortificato. E qui il problema è risolto strappando
alla parete rocciosa un sentiero largo non più di 2 metri, solo il
minimo indispensabile per far passare un quadrupede ma non permette
ad un esercito nemico di far arrivare le proprie schiere in massa
davanti ai battenti ferrati delle Porte o di utilizzare macchine da
guerra (ariete, torri mobili, ecc.) per sfondarla. Due limitati
sentieri, tagliati nelle pareti di roccia, danno accesso a due porte
(sec. XIII) che si aprono nella cinta muraria, Porta Milazzo e Porta
Messina, difese ognuna da un complesso fortificato autonomo,
identificato nel passato con il nome di Castello , composto ognuno
da torri, cisterne e alloggiamenti per la truppa.
In un sito adatto agli assedi non può mancare l’essenziale
approvvigionamento idrico. Conosciamo l’esistenza di quattro
cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Una è ancora visibile
nella sua interezza alla base della Torre Grande del Palatium;
un’altra nelle «ime sostruzioni» , nell’originaria piazza d’armi
dello stesso palazzo fortificato. Quest’ultima a differenza della
prima, aveva una capacità di raccolta superiore a quella vicina
della torre grande . La terza, anche questa ancora oggi integra, si
trova nella piazzetta della Chiesa bizantina ed emerge dal suolo
simile ad un pozzo da dove si attingeva il prezioso liquido.
L’ultima da noi conosciuta si trovava ad alcuni metri dalla parete
nord dello stesso edificio sacro, in Via Ardizzone, e fu distrutta
con la ristrutturazione intensiva dell’edilizia civile del secolo
scorso.
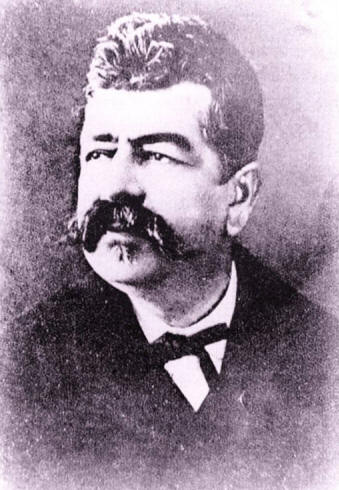
Giuseppe Seguenza (1833-1889) naturalista.
Ma le risorse di acqua a disposizione dell’abitato non si
esauriscono con le cisterne. Per resistere agli assedi la natura
aveva messo a disposizione una riserva idrica del tutto particolare.
Lasciamo la parola a Giuseppe Seguenza, il geologo messinese del XIX
sec. che studiò a fondo la struttura geologica del monte di Rometta.
Così dice il Seguenza:
[…] la rupe scoscesa su cui sta solidamente impiantata Rometta
benché isolata e molto alta, essa somministra ai suoi abitanti
limpidissima ed abbondante acqua potabile, che si procurano
agevolmente sin nelle più secche stagioni, forando dei pozzi pochi
metri profondi. Fenomeno veramente ammirevole .
A completare il dispositivo militare di sicurezza della
città-castello contribuiscono le diverse torri e torrette erette in
siti dominanti del sottostante circondario: in direzione nord-ovest
quali sono quelle di contrada Torretta (o Torrione) e di Scalone. Le
torri romettesi sono strutture di modeste dimensioni a guardia di
una strada o di un passo. La torretta del Palostrago risulta
inserita in un complesso più articolato rispetto alle altre, in
quanto costituiva un ridotto fortificato basato, in origine, su due
torrette gemelle circolari congiunte da uno spesso muro bastionato.
Riconosciuta dall’archeologo Scibona come un residuo dell’epoca
eroica bizantina, riutilizzata sino a tempi moderni, la struttura
muraria della superstite torretta orientale si presenta oggi con
blocchi lapidei di piccoli e di medie proporzioni di calcare locale
, legate con malta bianca. Lo spessore medio delle opere murarie
esterne, a differenza di quelle difensive del Palatium, è di un
metro in quanto era arduo e pressoché impossibile avvicinarsi con
macchine da guerra, atte a sfondare o essere raggiunti da altre armi
da gittata, trovandosi le mura su posizioni elevate e il sito su
un’area scoscesa solcata da profondi canaloni naturali. Il sistema
difensivo di Monte Palostrago è dotato di autonomia operativa,
completo di cisterne, per l’acqua piovana e pozzo, per quella
sorgiva, magazzini e abitazioni per il personale di vigilanza. Per
le necessità del personale addetto al sito si sfruttarono anche le
numerose grotte esistenti sul poggio. Tutto l’apparato militare
degrada verso il passo stradale sottostante dal quale passava (e
passa tutt’ora, Strada Prov.le 56) la via Milazzo prima di
immettersi nella vallata dominata dal Castello della porta
meridionale di Rometta.
Solitaria è la Torre circolare di Scalone, costruita sulla punta di
una erta collinetta a forma di un tronco di cono naturale sul cui
vertice si incastra perfettamente la struttura muraria. Le torri
romettesi rappresentano delle vere e proprie opere di difesa
avanzate, fungendo da sentinelle protese con gli sguardi verso il
Mar Tirreno, da dove giungono spesso le minacce rappresentate dalle
incursioni saracene prima, e ottomane dopo a bordo delle navi
barbaresche. Questo sistema difensivo risponde ad una precisa
volontà di bonificare militarmente una vasta area, quella più
esposta ad attacchi e, nel contempo, impedire che eventuali
avanguardie nemiche possano giungere di sorpresa davanti alle due
porte d’accesso della città-fortificata.
A
questa funzione preventiva contribuiscono anche altre due
posizioni fortificate, erette lontano dal territorio di Rometta. Sul
fianco destro, il piccolo Forte di Saponara, oggi denominato
Castello, vigila su un buon tratto di strada che porta ai valichi
peloritani ed è dotato di cisterna e di una piccola cortina muraria.
Più imponente si presenta il monte di Monforte, sulla cima del quale
è situata una costruzione militare munita di muro di cinta. La
collina turrita monfortese, oltre ad assicurare il fianco sinistro
opponendosi alle minacce provenienti dall’entroterra occidentale,
blocca un difficile sentiero alpestre che da Milazzo valica la
dorsale nei pressi di Monte Calogero. Tutte queste posizioni sono in
contatto visivo, in tal modo formano una rete comunicante efficiente
in grado di preallarmare in tempi celeri tutto il territorio,
Rometta compresa. E questo avviene con il sistema di comunicazione
ottica a distanza, già in uso presso gli antichi romani: il fuoco di
notte e il fumo di giorno.
Mentre al centro del pianoro abitato e dentro la cinta muraria si
trova un’altra struttura, protetto a sua volta da mura perimetrali,
spessi m. 1,50 e da due torri quadrate. Indicato con il nome di
Palatium ma anche erroneamente Castello, si trova eretto su un’ampia
balza rocciosa che emerge distintamente al centro dell’abitato
fornito di due cisterne e da vasti ambienti coperti predisposti per
la residenza del castellano e per le varie esigenze di
rappresentanza. Dentro la torre più piccola, separata dal corpo
principale dall’ampio cortile o piazza d’armi, due piani divisi di
cui adibiti a carcere quello inferiore e di guardia quello
superiore. Una porta ferrata, aperta sul muro perimetrale conduce al
cortile interno.
Rometta era una città murata, dotata di un notevole ed elaborato
apparato fortificato, in grado di sostenere l’importanza strategica
che rivestì per molti secoli.
(sia l'estratto che il volume completo degli Atti
pubblicati disponibili su questo sito nella pagina
Papers to Download)
|
|